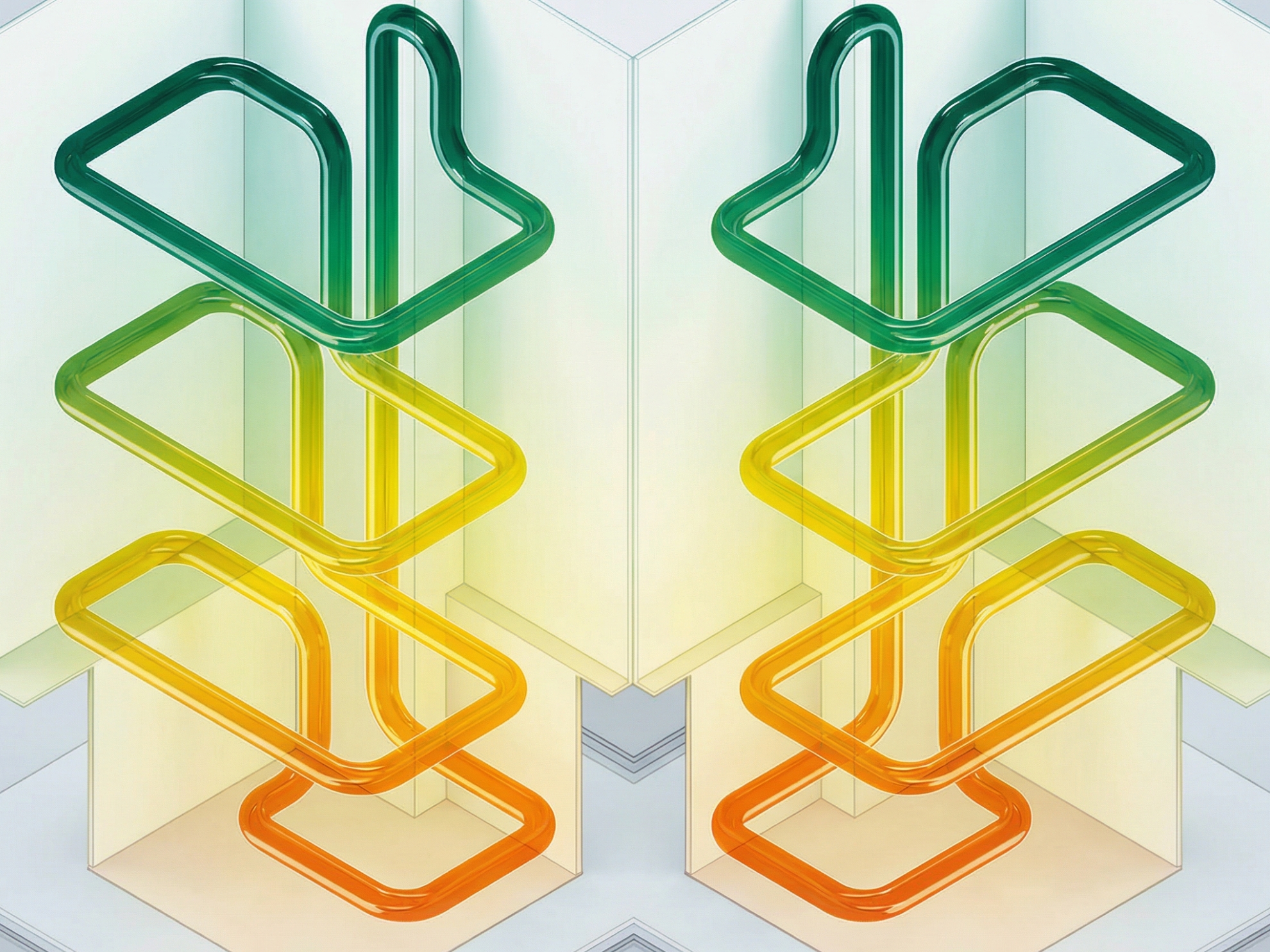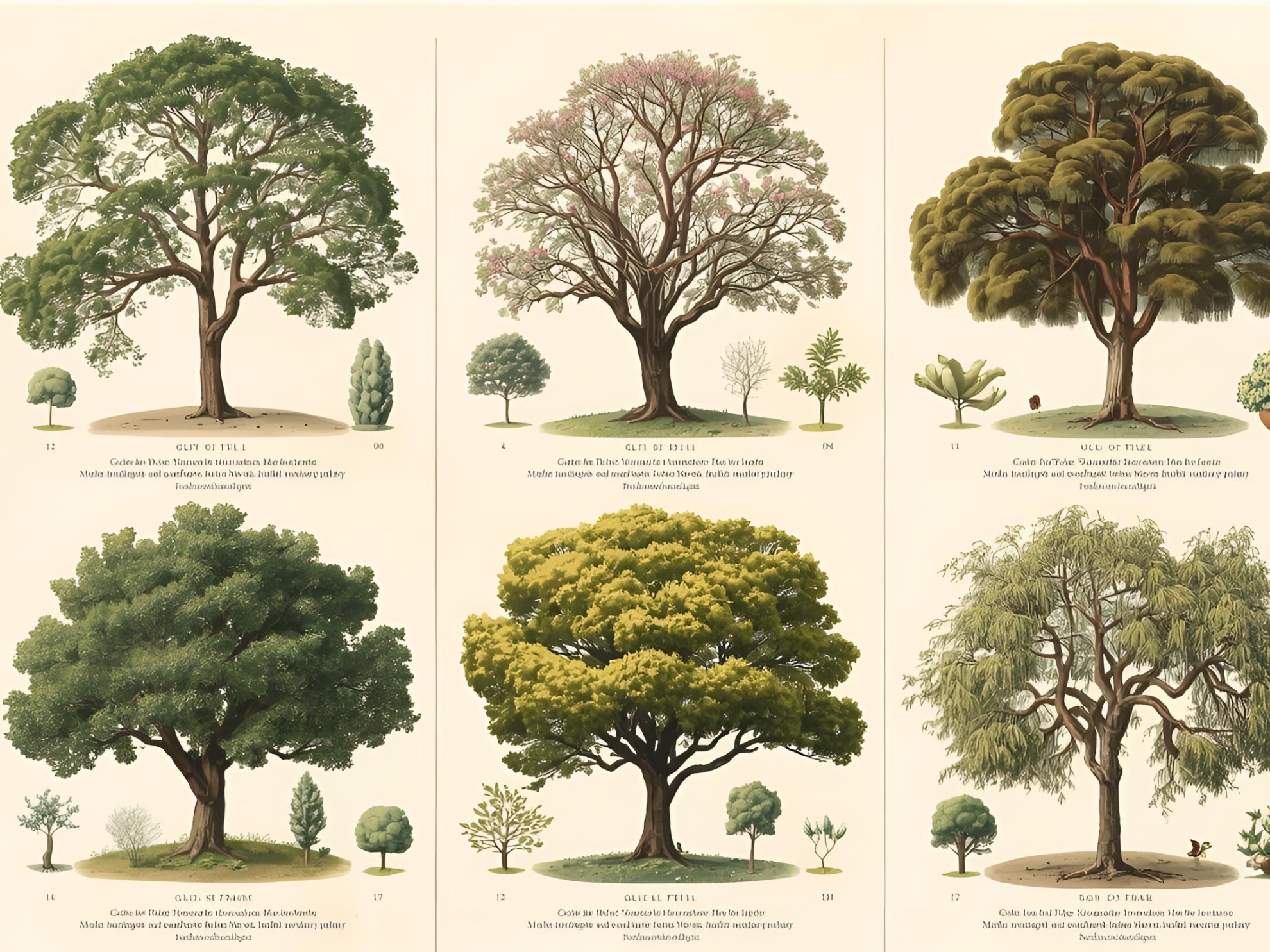Il tema, oggi al centro di un acceso dibattito tecnico e normativo, si inserisce perfettamente nell’evoluzione delle direttive europee sull’efficienza energetica degli edifici e risponde alle esigenze di chi opera tra vincoli strutturali, richieste di sostenibilità e necessità di cantieri rapidi.
Tra le soluzioni impiantistiche più efficienti, spiccano i sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia, progettati per rispondere alle esigenze della riqualificazione leggera, ma anche perfettamente adatti a nuove costruzioni ad alta prestazione. Queste tecnologie, ora pienamente normate (UNI EN 1264, UNI EN ISO 11855 e UNI 11944), offrono la possibilità di realizzare impianti a pavimento senza demolizioni, riducendo drasticamente tempi, costi e impatto ambientale.
La sfida della riqualificazione energetica
L’attenzione crescente verso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ ha portato a una revisione profonda delle strategie di intervento sugli edifici esistenti. Le recenti direttive europee (EPBD IV) impongono obiettivi ambiziosi: dal 2030, gli edifici dovranno essere a emissioni zero, mentre già dal 2025 sono venuti meno gli incentivi per l’installazione di sistemi alimentati da combustibili fossili.
In questo contesto, la riqualificazione impiantistica assume un ruolo centrale, soprattutto quando si tratta di intervenire su edifici storici o abitazioni dove non sono praticabili demolizioni invasive.
I sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia rispondono a queste esigenze: permettono infatti di integrare impianti efficienti anche in presenza di spazi ridotti, senza compromettere le quote architettoniche o la funzionalità degli ambienti.
Il loro sviluppo è stato accompagnato da un’evoluzione normativa che ne ha riconosciuto la validità tecnica e la conformità agli standard europei, grazie anche al contributo di enti di ricerca e università.
Soluzioni tecniche e vantaggi operativi
Il cuore della tecnologia a basso spessore e bassa inerzia risiede nella capacità di ridurre drasticamente lo spessore del pacchetto impiantistico, minimizzando la massa da riscaldare o raffrescare. Questo si traduce in una reattività superiore del sistema: la temperatura desiderata viene raggiunta in tempi molto più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali, con evidenti vantaggi sia in termini di comfort che di efficienza energetica. La minore inerzia termica consente inoltre di gestire in modo ottimale edifici utilizzati saltuariamente, come scuole, chiese o abitazioni stagionali, permettendo accensioni e spegnimenti rapidi senza sprechi.
Dal punto di vista normativo, la UNI EN 1264 e la UNI EN ISO 11855 hanno progressivamente recepito e definito le caratteristiche di questi sistemi, distinguendo tra soluzioni tradizionali, sistemi a spessore ridotto e veri e propri impianti a bassa inerzia. Un passo fondamentale è stato compiuto con la UNI 11944, che ha introdotto criteri chiari per la definizione dei massetti e delle stratigrafie idonee, aprendo la strada a sistemi con spessori sopra tubo inferiori anche a 15 mm.
L’applicazione pratica si traduce in una varietà di soluzioni: dalla fresatura dei pavimenti esistenti per l’inserimento delle tubazioni, fino all’utilizzo di lastre speciali o massetti leggeri consolidati con primer. Queste tecniche permettono di evitare demolizioni, ridurre i tempi di cantiere e limitare l’impatto ambientale, oltre a garantire la compatibilità con una vasta gamma di finiture, dal parquet alla resina, senza vincoli particolari sulle colle o sui materiali di posa.
Un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande rilevanza, è la possibilità di integrare i sistemi radianti nel processo edilizio, trasformando l’impianto da elemento “aggiunto” a vero e proprio componente strutturale. Dal punto di vista operativo, il sistema può infatti essere integrato in massetti leggeri, a secco o su supporti esistenti consolidati, senza intaccare le strutture portanti o compromettere le altezze disponibili.
Case study e prospettive future
I relatori hanno illustrato numerosi casi reali a testimoniare la versatilità di queste soluzioni: dagli interventi in edifici storici vincolati, dove la pavimentazione non può essere rimossa, alle nuove costruzioni in cui la rapidità di attivazione e la riduzione degli spessori diventano fattori decisivi. L’esperienza maturata in cantieri complessi, come scuole, palestre o spazi polifunzionali, conferma che la scelta di sistemi a basso spessore e bassa inerzia non è solo una risposta tecnica, ma una vera e propria strategia di progetto.
In un mondo che chiede edifici più intelligenti, performanti e sostenibili, i sistemi radianti a basso spessore rappresentano un modo per costruire – o ricostruire – tenendo insieme benessere abitativo ed efficienza energetica.
Sì. Soluzioni a basso spessore come quelle analizzate nel corso permettono la posa fresando direttamente la pavimentazione esistente, evitando demolizioni invasive. Questa tecnologia è particolarmente utile in ristrutturazioni leggere o in ambienti vincolati, come edifici storici.
Il vantaggio principale è la reattività termica: il sistema raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, riducendo i consumi. È ideale nel residenziale ma anche in edifici con occupazione variabile (scuole, uffici, seconde case, edifici di culto, strutture sportive), dove l’impianto non resta sempre acceso.
È compatibile con quasi tutte le finiture: piastrelle, parquet, resina, SPC, vinilico e persino pavimenti tecnici o galleggianti, purché si rispettino le indicazioni del produttore per l’adesione e la trasmissione del calore.
Il dimensionamento segue le norme UNI EN 1264 e UNI EN ISO 11855, con un’attenzione particolare alle perdite verso il basso e all’inerzia del sistema. Non è più complesso, ma richiede competenza tecnica per scegliere i materiali giusti e simulare correttamente il comportamento termico.
Non sempre. Le norme consentono di valutare la stratigrafia esistente per verificare se il pacchetto raggiunge la resistenza termica richiesta. In alternativa, si può utilizzare un software FEM (come AFEM) per simulare le perdite verso il basso.
Assolutamente sì. Secondo studi del Politecnico di Torino, il solo intervento impiantistico con pompa di calore e sistema radiante può portare a miglioramenti significativi (fino al -37% di energia primaria), contribuendo al salto di classe.