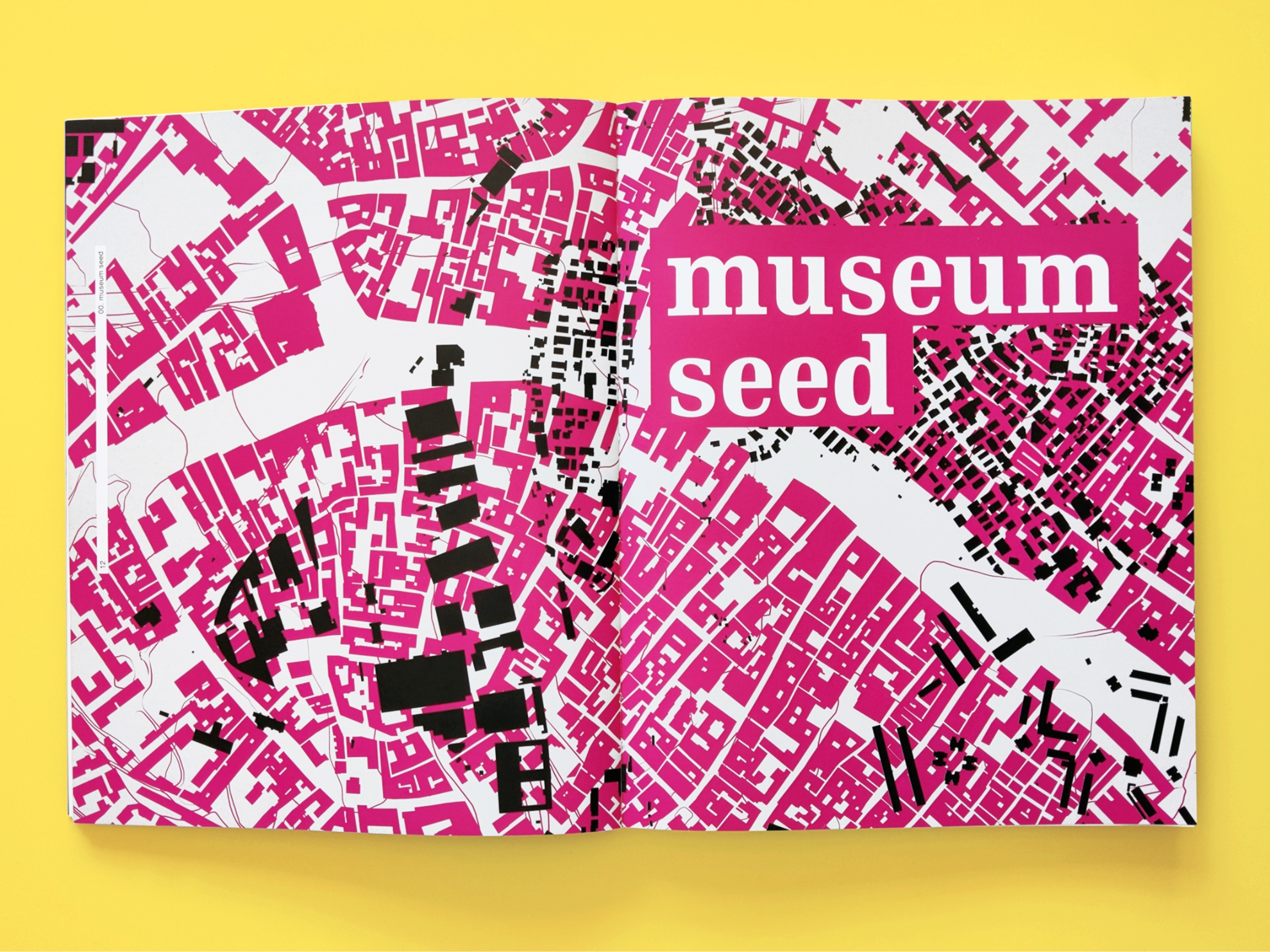Eppure, come dimostra l’esperienza trentennale di Luca Dini, fondatore dello studio LUCA DINI Design & Architecture con sede a Firenze, il dettaglio non è decorazione ma sostanza, non è accessorio ma essenza del progetto. Dalla progettazione di oltre cento mega yacht di lusso al master plan di un’intera isola in Arabia Saudita, l’approccio di Dini ribalta la gerarchia tradizionale: spesso il progetto non parte da una visione generale per poi scendere al particolare, ma nasce proprio da un materiale, da una texture, da una soluzione artigianale che diventa generatrice dell’intero organismo architettonico.
L’incontro organizzato dalla Fondazione Bisazza offre l’opportunità di esplorare questa filosofia progettuale che coniuga innovazione tecnologica e sapere artigianale, visione contemporanea e radici territoriali profonde, ambizione internazionale e fedeltà ai valori della tradizione manifatturiera italiana.
La nautica come scuola del dettaglio
Il percorso professionale di Luca Dini inizia nel mondo della nautica, la palestra perfetta per sviluppare un’attenzione maniacale al dettaglio. Come racconta egli stesso, chi acquista uno yacht da ottanta o centotrenta metri rinuncia consapevolmente alla metratura: con gli stessi investimenti potrebbe acquistare dieci volte i metri quadri in un contesto residenziale. La scelta di vivere in piccoli spazi richiede che quell’ambiente ristretto offra un’esperienza assolutamente unica, disegnata su misura, che giustifichi la rinuncia allo spazio. Questa esigenza ha forgiato un metodo progettuale dove ogni centimetro conta, dove la personalizzazione diventa totale, dove l’artigianalità e la cura dei materiali non sono optional ma necessità funzionale.
Nel 2016 il principe ereditario Mohammad bin Salman partecipa a una festa su uno yacht progettato da Dini. Il Sea Force One era stato concepito come esperienza, con quindici artisti contemporanei che realizzarono opere site-specific direttamente a bordo. Non opere acquistate e portate a bordo, ma create specificamente per quegli spazi, trasformando l’imbarcazione in un’installazione artistica navigante. Il principe ne rimane talmente colpito da voler conoscere il progettista. Dopo una serie di incontri surreali, nasce un rapporto professionale che porta prima alla progettazione di due yacht straordinari, poi al master plan dell’isola Sindalah all’interno del faraonico progetto Neom.
Il mosaico come metafora progettuale
La libertà di iniziare dal particolare per arrivare al generale richiede curiosità, apertura mentale, capacità di vedere potenzialità inedite nei materiali. La metafora del mosaico permea tutto l’approccio progettuale di Dini e rappresenta perfettamente la filosofia che guida il suo lavoro. Ogni tessera, presa singolarmente, appare piccola, unica, apparentemente insignificante. Ma quando viene posizionata accanto ad altre tessere, quando si inserisce in una visione generale, quella stessa tessera acquisisce un valore incredibile. Il master plan diventa letteralmente un mosaico dove ogni elemento costruito, ogni materiale, ogni dettaglio contribuisce a creare un’immagine complessiva armoniosa.
Questo approccio si traduce in una metodologia progettuale rovesciata: molti progetti non partono da un’idea generale per poi definire i materiali, ma nascono proprio da un materiale specifico che suggerisce l’intera architettura. Nel progetto dell’isola di Sindalah, ad esempio, ogni componente è stato studiato come tessera di un mosaico più ampio. Le colonne in quarzo retroilluminate diventano struttura portante e elemento scenografico. Il policarbonato che l’azienda Edra utilizza per realizzare poltrone e tavoli ispira le facciate trasparenti dei bungalow, trasformando un elemento di design d’interni in soluzione architettonica innovativa. Il mosaico di vetro realizzato dai vetrai di Ravenna riveste i soffitti di tutta la promenade. Quest’ultimo caso è particolarmente significativo: un prodotto artigianale pensato come quadro da appendere, presentato da giovani che realizzavano una formella al mese, è diventato rivestimento di migliaia di metri quadri grazie alla scommessa del committente e alla capacità di industrializzare un processo artigianale mantenendone la qualità. Un altro esempio illuminante è stata la collaborazione con un setificio del ‘700 che produce trenta centimetri di tessuto al giorno utilizzando un orditoio disegnato da Leonardo da Vinci.
L’artigianalità è diventata il vero lusso, superando l’idea di ostentazione: il lusso autentico è l’artigianalità, il fatto su misura, il pensato e creato appositamente per quella persona specifica. Oggi gli armatori più sofisticati chiedono yacht silenziosi per non disturbare gli altri al porto la mattina, materiali preziosi ma lavorati con eleganza. Richiedono l’esclusività della customizzazione totale, l’esperienza unica che solo l’intervento artigianale può garantire. In una cabina di venticinque metri quadri su uno yacht da centoquaranta metri con centootto persone di equipaggio per diciotto ospiti, ogni dettaglio deve essere perfetto: la cucitura della pelle, il colore del punto, la parallela del doppio punto richiedono mesi di studio con gli artigiani.
Il valore della manualità nel processo creativo
Nonostante la disponibilità di strumenti digitali avanzati, Dini mantiene una fedeltà assoluta al disegno manuale nelle fasi iniziali della progettazione. Tradurre direttamente al computer ciò che si ha in mente risulta impossibile: serve il passaggio attraverso la mano, la matita, il foglio. Il team si riunisce, disegna, confronta soluzioni con un metodo che ricorda gli anni Ottanta. Questa pratica viene talvolta derisa come approccio da “boomer”, ma il gusto che offre la progettazione manuale non può essere replicato dal programma digitale. Le moodboard, le tavole dove si accostano materiali, campioni, texture, colori, diventano quasi opere d’arte quando vengono fotografate. Ogni tessera presa singolarmente ha un suo valore, ma quando si combinano tutte insieme, esattamente come fa Bisazza con i mosaici, l’insieme diventa armonioso e superiore alla somma delle parti. Il processo di selezione e accostamento dei materiali non è decorazione finale ma parte integrante della concezione progettuale.
L’importanza attribuita alla manualità si estende alla formazione dei collaboratori. Dini organizza visite negli atelier artigiani per i giovani dello studio, molti dei quali non hanno mai visto cosa significa “fatto a mano”. Una generazione cresciuta scegliendo dal catalogo, combinando elementi prefabbricati, rischia di perdere la comprensione profonda di cosa significhi creare un oggetto unico attraverso il lavoro dell’artigiano. Vedere persone che mettono tessera per tessera un mosaico, che cuciono a mano una pelle, che lavorano il legno centimetro per centimetro crea un’emozione che si trasforma in consapevolezza progettuale.
Progetti di riqualificazione urbana: via Palazzuolo a Firenze
L’approccio basato sul dettaglio e sull’artigianalità trova applicazione anche in progetti di rigenerazione urbana con budget limitati. Il progetto Recreos per via Palazzuolo a Firenze dimostra che non servono investimenti monumentali per riqualificare contesti degradati, ma visione, collaborazione e attenzione ai materiali. Via Palazzuolo, a centocinquanta metri dal Duomo, era una strada abbandonata caratterizzata da criminalità e spaccio. La Fondazione Cassa di Risparmio ha chiesto a Dini un’idea replicabile anche in altre città italiane con problematiche simili.
La soluzione proposta parte dalla pavimentazione: eliminare l’asfalto, utilizzare pietre tradizionali fiorentine (pietra serena), creare un disegno ispirato alla Cappella dei Pazzi distribuendo sulla strada simboli significativi dell’architettura fiorentina. In questi cerchi decorativi vengono inserite opere ispirate al giardino di Boboli, creando un percorso culturale: totem con QR code permettono ai passanti di scoprire da quale opera è tratto quel cerchio, chi l’ha disegnato, dove si conserva l’originale. Camminando per fare la spesa o andare al lavoro si attraversa un museo a cielo aperto.
Il verde viene integrato nel progetto, l’illuminazione studiata specificamente, i parcheggi ridotti ma compensati da accordi con garage della zona per residenti. Il costo complessivo rimane contenuto grazie alla collaborazione: i vivai di Pistoia donano le piante in cambio di visibilità, i fornitori di pietra contribuiscono in cambio di pubblicità. Quando c’è volontà di collaborare per il bene comune, si possono realizzare progetti di qualità con risorse limitate. Il successo è stato tale che da tutta Italia sono arrivate richieste per replicare il format in altre città.
Albania: laboratorio di sperimentazione architettonica
L’Albania rappresenta oggi secondo Dini l’unico paese europeo dove si fa veramente architettura sperimentale. Il primo ministro Edi Rama, innamorato dell’architettura, ha creato un gruppo WhatsApp con duecento studi internazionali dove si scambiano idee, opinioni, progetti. Il paese sta attraversando una trasformazione radicale che offre opportunità straordinarie a progettisti, ingegneri, designer, grafici. I progetti in corso dimostrano come sia possibile coniugare sperimentazione materica e sostenibilità.
Per un edificio a Tirana, Dini ha utilizzato un macchinario che stampa in 3D direttamente sul posto un agglomerato di cemento e terracotta riciclata direttamente in cantiere senza trasporti internazionali. L’esperimento, fortemente voluto contro tutti i pareri contrari perché non era mai stato fatto, ha dimostrato vantaggi significativi: zero trasporti (il macchinario viene smontato e montato in loco), zero inquinamento da logistica, utilizzo di materiale riciclato. Normalmente per scegliere quattro lastre di marmo un team si sposta tra Pietrasanta, Carrara e Verona, dove i marmi arrivano dal Brasile…per un bagno si movimenta il mondo intero.
Per due torri a Durazzo è stato utilizzato legno riciclato stampato con lo stesso macchinario, che viene spostato da città a città ma rimane in Albania. L’edificio, ispirato a un “living canyon”, prevede che la parte bassa delle torri diventi piazza pubblica per la città, restituendo spazio alla popolazione e permettendo alle unità abitative superiori di avere vista sul mare. Il costruttore ha combattuto contro questa scelta perché lo spazio pubblico riduce i metri cubi da vendere, ma la spinta governativa ha prevalso, dimostrando che è possibile fare architettura non solo per il committente privato ma anche per la collettività.
È questo un tema ricorrente nell’intervento di Dini: la responsabilità del progettista verso le persone che vivranno gli spazi progettati. La tentazione dell’autocelebrazione, del progetto che soddisfa l’ego o il potere piuttosto che le esigenze degli utenti, rappresenta un rischio costante contro cui combattere quotidianamente. Basti pensare a Dubai, progettata inizialmente per due milioni e mezzo di abitanti, poi per tre, ora proiettata verso nove-undici milioni: una città dove il traffico è diventato impossibile, dove le persone scelgono la casa in funzione del lavoro per evitare spostamenti quotidiani insostenibili. L’errore di pianificazione si trasforma in condizione esistenziale degradata per milioni di persone, e questo deve sempre essere evitato.
Il principio del mosaico permette di operare su scale diverse mantenendo coerenza: ogni tessera conta, dal master plan al dettaglio costruttivo. Nel progetto di Neom, decidere con due paline dove inizia e finisce una città da 80.000 abitanti è un gesto di scala territoriale, ma poi ogni edificio, ogni spazio pubblico, ogni pavimentazione viene studiato con la stessa cura degli interni di uno yacht. La chiave è la visione d’insieme che guida le scelte di dettaglio, assicurando che ogni elemento contribuisca all’identità complessiva. Il progetto di via Palazzuolo dimostra che anche su 300 metri di strada la cura del dettaglio (pavimentazione, QR code, illuminazione) trasforma l’intervento in esperienza culturale.
L’approccio che parte dal materiale o dal dettaglio non implica necessariamente costi elevati, ma richiede curiosità e capacità di trovare soluzioni innovative. La chiave è identificare il dettaglio generatore che dà identità al progetto senza necessariamente moltiplicare i costi. Partire dal materiale rappresenta un processo progettuale legittimo e spesso più innovativo del metodo tradizionale. L’hotel realizzato con policarbonato Edra nasce dall’innamoramento per quel materiale specifico, che poi ha generato l’intero concept architettonico. Questo approccio richiede conoscenza approfondita dei materiali, frequentazione di fornitori e artigiani, curiosità verso applicazioni non convenzionali. Visitare fiere, laboratori artigianali, aziende produttrici permette di scoprire materiali con potenzialità non sfruttate. La scommessa con il committente diventa fondamentale: “perché non proviamo a fare qualcosa di particolare con questo materiale?” trasforma la proposta in esperienza innovativa.
La manualità nel disegno iniziale rimane fondamentale perché tradurre direttamente al computer ciò che si ha in mente risulta impossibile per molti progettisti. Il passaggio attraverso la mano, la matita, il foglio permette una libertà espressiva e una fluidità che il software non replica nelle fasi creative iniziali. Le moodboard con materiali fisici accostati diventano strumenti di progettazione che, quando fotografati, assumono valore di opere d’arte. Il digitale interviene successivamente per sviluppare tecnicamente ciò che è nato manualmente, ma la fase generativa del progetto mantiene un legame forte con il disegno tradizionale che facilita la comunicazione all’interno del team e con gli artigiani.
La nautica è stata la palestra perfetta per sviluppare attenzione maniacale al dettaglio. Chi acquista uno yacht da ottanta metri rinuncia consapevolmente alla metratura e sceglie di vivere in camere di venticinque metri quadri quando possiede intere ville. Per giustificare questa scelta serve che ogni centimetro sia perfetto, customizzato, unico. La necessità di ottimizzare spazi ristretti, di integrare funzioni complesse, di garantire qualità assoluta in ogni dettaglio ha forgiato un metodo che si trasferisce perfettamente all’architettura.
La sostenibilità è parte della ricerca di materiali innovativi e processi produttivi a basso impatto. La stampa 3D in cantiere di agglomerati di cemento e terracotta riciclata elimina trasporti intercontinentali, azzera inquinamento da logistica, utilizza materiali di scarto. Non tutti gli esperimenti riescono (la pelle da acini d’uva è stata un fallimento), ma provare è necessario. Sostenibilità non significa rinunciare alla bellezza ma ripensare i processi: meno movimentazione, più locale, materiali riciclati o a basso impatto, collaborazioni con realtà territoriali. Serve un committente che scommette, ma i risultati dimostrano che sostenibilità e qualità estetica non sono antitetiche.
Perché l'artigianalità italiana rappresenta un vantaggio competitivo distintivo nel mercato globale?
L’Italia possiede un ecosistema artigianale unico: fabbriche familiari con 20-50 persone capaci di produrre centinaia o migliaia di pezzi annui mantenendo intervento manuale qualificato. Questa fascia intermedia non esiste in Germania (che ha grandi industrie o singoli artigiani) né in Francia (con artigiani individuali non strutturati). Vivere in città come Firenze significa respirare quotidianamente arte e cultura che hanno formato sensibilità progettuali per secoli: questa eredità è “nel sangue” anche senza studio specifico. All’estero riconoscono e invidiano questa capacità di coniugare creatività progettuale ed eccellenza esecutiva artigianale. Il setificio del Settecento, gli artigiani del vetro, i maestri d’ascia che costruiscono yacht in alluminio rivestiti di mogano rappresentano patrimonio inimitabile.