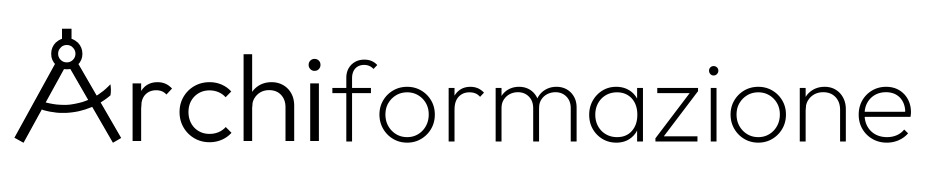Il Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) utilizza queste espressioni in articoli diversi, generando non di rado incertezza interpretativa anche tra i professionisti più esperti. L’articolo 31 parla di “totale difformità”, l’articolo 32 definisce le “variazioni essenziali”, l’articolo 34 tratta le “parziali difformità”, mentre l’articolo 22 introduce le “varianti a permessi di costruire che non configurano variazione essenziale”. Si tratta davvero di concetti distinti o di semplici sfumature lessicali? Per comprendere appieno le problematiche attuali occorre ripercorrere brevemente l’evoluzione storica della disciplina dei titoli abilitativi edilizi. La sistematizzazione normativa è arrivata relativamente tardi nel nostro ordinamento: con la legge 1150 del 1942 venne introdotta la licenza di costruzione, che rimase in vigore fino al 1977. La legge Bucalossi (legge 10/1977) operò una rivoluzione concettuale, trasformando la licenza in concessione edilizia e introducendo il principio secondo cui ogni attività comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio è soggetta a concessione. Questo rappresentò un cambio di paradigma: non più un elenco tassativo di interventi soggetti a controllo, ma una regola generale di assoggettamento. Con la legge 457 del 1978, venne introdotta l’autorizzazione edilizia per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportassero il rilascio dell’immobile. Il ministro Nicolazzi estese progressivamente l’ambito applicativo delle autorizzazioni, gratuite e penalmente non rilevanti, ad altri interventi come il restauro e risanamento conservativo. Si iniziò così una differenziazione del regime tra concessione edilizia e autorizzazione edilizia, che divenne sistematica con la legge 47 del 1985. Questa stratificazione normativa ha creato un sistema complesso in cui convivono regole riferite a epoche diverse, ciascuna con propria terminologia e propri effetti giuridici. Quando si deve valutare lo stato legittimo di un edificio o sanare interventi eseguiti in passato, occorre quindi applicare il principio del “tempus regit actum”: le valutazioni devono essere effettuate secondo le leggi vigenti nel momento in cui è stata compiuta l’azione, non secondo la legislazione attuale.
Il concetto di variante: tra senso proprio, varianti minori ed essenziali
Esistono le varianti leggere o minori, le varianti in senso proprio e le varianti essenziali. Questa distinzione, apparentemente sottile, produce conseguenze giuridiche fondamentali. Le varianti leggere o minori sono quelle che non incidono sui parametri urbanistici fondamentali del progetto approvato. Si tratta di modifiche di dettaglio, aggiustamenti esecutivi, scelte tecniche che non alterano la sostanza dell’intervento autorizzato. Queste varianti possono essere realizzate senza necessità di nuovo titolo abilitativo, purché non configurino variazione essenziale ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico.
Le varianti in senso proprio rappresentano modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non compromettere o portare a un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello approvato. La giurisprudenza ha chiarito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5854/2018 che queste varianti sono soggette al rilascio di un permesso di variante, il quale è complementare e accessorio anche sotto il profilo temporale della normativa operante rispetto all’originario permesso di costruire. Questo significa che le varianti in senso proprio mantengono la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel momento del rilascio del titolo abilitativo originario, non vanno a modificare i termini di inizio e fine lavori e sono ammissibili nonostante eventuali sopravvenienze normative. Il titolo abilitativo originario diventa la fonte legittimante per la disciplina applicabile.
Le varianti essenziali si caratterizzano invece per un’incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio rispetto ai parametri urbanistici fondamentali. Sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario, per il quale valgono le disposizioni vigenti nel momento della realizzazione della variante. La differenza è sostanziale: mentre per le varianti in senso proprio la valutazione di conformità si effettua rispetto alla norma vigente al momento del rilascio del permesso di costruire originario, per le varianti essenziali la conformità va verificata rispetto al momento del compimento dell’esecuzione della variante stessa. Questo implica che una variante essenziale deve confrontarsi con eventuali modifiche normative sopravvenute, nuovi vincoli, diversi parametri urbanistici introdotti successivamente al titolo originario.
Le variazioni essenziali: una categoria normativa distinta
Accanto alle varianti, il legislatore ha introdotto il concetto di variazione essenziale, disciplinato dall’articolo 32 del Testo Unico. L’essenzialità della variazione costituisce una caratteristica giuridica rilevante perché determina l’impossibilità di sanatoria tramite accertamento di conformità. Le variazioni essenziali vengono equiparate, quanto alle conseguenze sanzionatorie, alla totale difformità rispetto al titolo abilitativo. Il legislatore ha demandato alle Regioni il compito di stabilire quali interventi costituiscano variazioni essenziali, indicando però alcuni parametri orientativi: mutamento delle destinazioni d’uso che implichi variazioni degli standard urbanistici, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, cambiamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, violazioni delle norme in materia edilizia antisismica.
In Veneto, per esempio, costituisce variazione essenziale un aumento dell’occupazione superiore al venti percento, quindi a un quinto del volume originario, o un incremento dell’altezza superiore a un terzo. Altre Regioni hanno adottato parametri diversi, creando un panorama normativo regionale non omogeneo che impone al professionista di verificare attentamente la disciplina applicabile nel territorio di intervento. La norma statale precisa che non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici o sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Questa specifica circoscrive l’ambito delle variazioni essenziali agli aspetti urbanisticamente rilevanti, escludendo modifiche interne o di dettaglio tecnico.
Il concetto di difformità: totale, parziale e residuale
La difformità rappresenta la categoria più ampia e problematica. L’articolo 31 definisce gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire come quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente realizzabile. Questa definizione ha storicamente costituito un aggancio utilizzato dalla giurisprudenza per qualificare come nuove costruzioni le ristrutturazioni edilizie con diverse caratteristiche tipologiche e planivolumetriche. Le modifiche legislative successive hanno però inserito queste ipotesi nell’ambito della definizione di ristrutturazione edilizia, generando un complesso intreccio interpretativo.
Le difformità parziali sono disciplinate dall’articolo 34 e rappresentano una categoria residuale: è difformità parziale tutto ciò che non costituisce difformità totale ai sensi dell’articolo 31. Non esiste una definizione positiva di difformità parziale, ma solo un criterio di esclusione. Questo crea margini di incertezza nella qualificazione degli interventi, incertezza che viene risolta ricorrendo all’interpretazione giurisprudenziale e all’analisi sostanziale del caso concreto. Una precisazione fondamentale riguarda la distinzione tra varianti e difformità: le varianti sono richieste di modifica del titolo autorizzativo presentate prima dell’esecuzione o durante l’esecuzione dei lavori, mentre le difformità emergono a lavori conclusi o quando non è stata richiesta preventivamente la variante. In sostanza, una variante non comunicata o non autorizzata che viene scoperta al termine dei lavori si trasforma in difformità. Questo significa che anche una modifica che singolarmente considerata costituirebbe una variante in senso proprio o minore, se non viene dichiarata nei tempi e nei modi previsti, può configurare una difformità con le relative conseguenze sanzionatorie. Il momento della dichiarazione diventa quindi cruciale.
L’abuso edilizio: formale e sostanziale
Il Testo Unico dell’edilizia non fornisce una definizione espressa di abuso edilizio, ma attraverso il Titolo IV dedicato alla vigilanza sull’attività edilizia e alle sanzioni è possibile ricavarne i contorni. Può definirsi abuso edilizio qualsiasi attività oggetto di disciplina urbanistico-edilizia per la quale il Testo Unico prevede una sanzione, un accertamento di conformità, la possibilità di annullamento del titolo abilitativo, oppure che rientra nelle finalità della vigilanza sull’attività edilizio-urbanistica. L’articolo 27 stabilisce che il dirigente responsabile esercita la vigilanza per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L’abuso si configura quindi quando l’attività edilizia viene eseguita con un titolo diverso da quello previsto dal legislatore, o in assenza del titolo richiesto.
La giurisprudenza ha operato una distinzione fondamentale tra abuso formale e abuso sostanziale. L’abuso formale attiene al titolo: eseguire un intervento senza il titolo richiesto o con un titolo diverso da quello necessario costituisce abuso formale anche quando l’opera sia conforme alla disciplina urbanistica sostanziale. L’abuso sostanziale riguarda invece la disciplina conformativa vera e propria: l’opera è difforme rispetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, ai vincoli, indipendentemente dall’esistenza di un titolo formalmente idoneo. La Cassazione Penale ha chiarito che il titolo abilitativo per la sua natura non è sufficiente a definire lo statuto edilizio-urbanistico di legittimità dell’intervento senza verificare il quadro delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Il principio di tipicità e nominatività: il nomen iuris e la sostanza
Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra la denominazione formale del titolo abilitativo e la sua sostanza giuridica. Nel diritto amministrativo vige il principio di tipicità e nominatività degli atti della pubblica amministrazione: gli interventi edilizi devono essere ricondotti alle categorie previste dalla legge, ciascuna con il proprio titolo abilitativo specifico. Il legislatore ha stabilito cosa costituisce attività edilizia libera, cosa richiede CILA, cosa è soggetto a SCIA e cosa necessita di permesso di costruire. Non è consentito “scendere” di livello, presentando per esempio una SCIA quando sarebbe richiesto il permesso di costruire, mentre è generalmente accettato che “il titolo maggiore copra il minore”: ottenere un permesso di costruire per un’opera soggetta a SCIA è considerato legittimo perché si sottopone l’intervento al controllo più intenso.
La questione si complica quando il titolo viene denominato in modo improprio. Alcune leggi regionali prevedono titoli con denominazioni non perfettamente coincidenti con quelle del Testo Unico, o modulistiche che creano varianti terminologiche. La giurisprudenza ha progressivamente affermato che la qualificazione giuridica dell’intervento non dipende dalla denominazione utilizzata ma dall’incidenza oggettiva della modifica sugli elementi essenziali dell’intervento assentito. Si prescinde dal “nomen iuris” che viene attribuito e si effettua una verifica di natura sostanziale.
Intelligenza artificiale e interpretazione normativa: opportunità e limiti
Un aspetto innovativo che emerge dalla pratica professionale riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’interpretazione delle norme urbanistiche ed edilizie. La disponibilità di strumenti di AI generativa ha aperto nuove possibilità ma anche evidenziato limiti significativi. L’intelligenza artificiale lavora sulla ripetizione e sulla mappatura dell’esistente, ma quando si avvicina a questioni che richiedono innovazione interpretativa o applicazione di principi giuridici complessi può fornire risposte errate o incomplete. Un esempio concreto riguarda l’applicabilità dell’articolo 24, comma 5-bis, del Testo Unico, introdotto dal Decreto Salva Casa, che consente di asseverare alloggi monostanza con altezze e superfici ridotte rispetto ai parametri ordinari.
Interrogando diversi sistemi di intelligenza artificiale sulla questione se questa norma si applichi anche alle nuove costruzioni, la risposta ottenuta è stata pressoché unanimemente affermativa, con la motivazione che il testo del comma non specifica un campo di applicazione limitato. Tuttavia, un’interpretazione sistematica della disposizione, che tenga conto della sua collocazione nell’articolo, del collegamento con i commi 5-ter e 5-quater, della natura derogatoria della norma, porta a concludere tutt’altro come evidenziato dal relatore. Questo esempio mostra come l’intelligenza artificiale, pur potendo costituire un ausilio nella ricerca normativa, non possa sostituire la competenza tecnico-giuridica del professionista. È necessario “controinterrogare” l’AI, indicandole i collegamenti sistematici tra le norme, le interpretazioni giurisprudenziali consolidate, i principi generali dell’ordinamento. Solo attraverso questo processo di verifica critica l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento utile anziché una fonte di errori potenzialmente gravi.
Una delle situazioni più complesse nella pratica professionale riguarda gli interventi che si realizzano in più fasi temporali, spesso con interruzioni dovute a difficoltà finanziarie del committente, contenziosi, o altre cause che determinano la decadenza del titolo originario. L’articolo 15 del Testo Unico stabilisce che il permesso di costruire decade se i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio o se vengono interrotti per oltre tre anni. La decadenza comporta la necessità di richiedere un nuovo permesso per completare l’opera, ma qui sorgono problematiche rilevanti.
La prima questione riguarda la definizione di edificio “esistente”. Un edificio realizzato al rustico ma non completato può essere considerato esistente? La seconda questione attiene alla disciplina applicabile. Se il titolo originario è decaduto e viene richiesto un nuovo titolo per il completamento, quale disciplina urbanistica si applica? Quella vigente al momento del titolo decaduto o quella vigente al momento della nuova richiesta? Il principio del “tempus regit actum” imporrebbe l’applicazione della disciplina attuale, ma occorre distinguere. Se la decadenza è intervenuta per inerzia del titolare che non ha iniziato i lavori, il nuovo titolo dovrà confrontarsi con l’eventuale sopravvenienza di previsioni urbanistiche contrastanti. L’articolo 15 prevede infatti che il permesso di costruire decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dall’inizio. Se invece i lavori erano stati iniziati e poi interrotti, la situazione è più sfumata.
Una terza questione riguarda il collaudo statico. Se l’edificio è stato realizzato al rustico ma non è stato eseguito il collaudo delle strutture in cemento armato, si configura una violazione specifica. Il collaudo statico va effettuato prima del caricamento delle strutture, quando queste sono complete ma non ancora sotto carico. La mancata esecuzione del collaudo costituisce illecito ma non impedisce di considerare l’edificio esistente ai fini urbanistici, purché le strutture siano state effettivamente realizzate. Il completamento dell’edificio richiederà comunque l’esecuzione tardiva del collaudo, con le relative sanzioni previste dalla normativa sulle opere in conglomerato cementizio.
Il Testo Unico, nell’articolo 22, comma 2, prevede che “sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale”. Sembrerebbe quindi che la SCIA in variante sia espressamente prevista a livello nazionale. Tuttavia, l’interpretazione letterale deve essere coordinata con la struttura complessiva del sistema dei titoli abilitativi e con la natura giuridica della SCIA.
La SCIA è un titolo abilitativo procedimentale che produce efficacia immediata: decorsi 30 giorni senza che l’amministrazione adotti provvedimenti inibitori, l’attività può essere iniziata. Non esiste un provvedimento espresso di autorizzazione, ma solo l’eventuale silenzio-assenso dell’amministrazione che non interviene. Questa caratteristica rende problematico concepire una “SCIA in variante” a un permesso di costruire già rilasciato. Come può una segnalazione modificare un provvedimento amministrativo espresso? Tecnicamente, la SCIA non è una “variante” ma un nuovo titolo autonomo che si affianca al permesso originario, con la particolarità di poter essere presentata in corso d’opera e di mantenere alcuni collegamenti con il titolo precedente.
Alcune leggi regionali hanno espressamente previsto la possibilità di SCIA in variante, disciplinando modalità e requisiti. In questi casi, la fonte regionale colma le lacune interpretative della disciplina nazionale e fornisce un quadro operativo più chiaro. Dove invece la legge regionale non preveda espressamente questo istituto, ci si trova di fronte a un vuoto normativo significativo.
Il modello BIM non è un semplice insieme di elaborati grafici bidimensionali, ma un database tridimensionale integrato che contiene informazioni geometriche, tecniche, prestazionali, economiche e manutentive. Questa caratteristica pone questioni inedite rispetto alla disciplina tradizionale delle varianti.
In primo luogo, il BIM rende immediatamente evidenti anche le minime modifiche al progetto. Nel sistema tradizionale, piccole variazioni esecutive potevano essere assorbite nei margini di tolleranza degli elaborati grafici bidimensionali. Nel modello BIM, ogni modifica è tracciata e documentata con precisione millimetrica. Questo da un lato aumenta la trasparenza e la verificabilità degli interventi, dall’altro può generare rigidità eccessive. Se ogni minima variazione dovesse essere formalmente autorizzata, i cantieri rischierebbero la paralisi. Diventa quindi fondamentale individuare soglie di rilevanza al di sotto delle quali le modifiche possono essere considerate fisiologiche variazioni esecutive e non varianti richiedenti titolo.
In secondo luogo, il BIM modifica il concetto stesso di “elaborato progettuale”. Tradizionalmente, il progetto approvato è costituito da tavole grafiche, relazioni, computi. Nel BIM, il progetto è il modello tridimensionale, da cui vengono estratte le tavole. Ma cosa succede se le tavole estratte presentano incongruenze rispetto al modello? Quale prevale? E se il committente modifica autonomamente il modello BIM cedutogli dal progettista, realizzando poi l’edificio secondo il modello modificato, si configura una variante non autorizzata oppure un intervento difforme? La risposta non è scontata.
In terzo luogo, il BIM ha implicazioni rilevanti sulla ricostruzione dello stato legittimo. Il Decreto Legislativo 36/2023 spinge fortemente verso la digitalizzazione e l’adozione del BIM nei contratti pubblici, prevedendo che progressivamente tutti gli interventi pubblici siano progettati, realizzati e gestiti tramite BIM. Questo significa che la pubblica amministrazione acquisirà modelli digitali completi degli edifici pubblici, con enormi potenzialità per la gestione e manutenzione ma anche con rischi per il diritto d’autore del progettista e la titolarità dei dati.