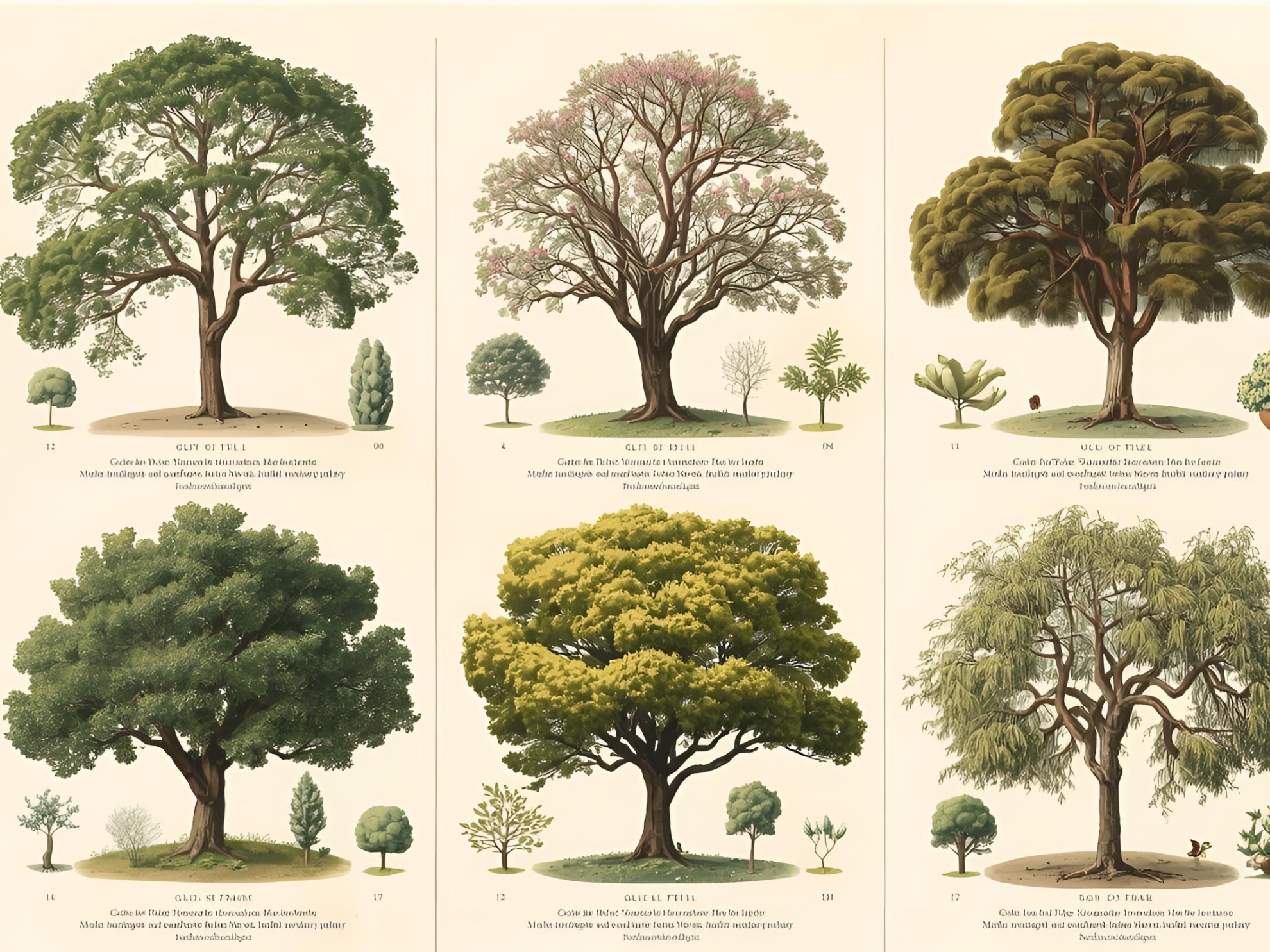Le case in legno rappresentano oggi una scelta sempre più diffusa nel panorama edilizio, grazie a durabilità, sostenibilità e prestazioni energetiche. Tuttavia, la progettazione di queste strutture richiede un approccio metodico per bilanciare creatività architettonica, efficienza tecnica e rispetto dei vincoli normativi.
Le sfide principali includono la gestione delle interazioni tra materiali, logistica e prestazioni termoacustiche, mentre le opportunità risiedono nella rapidità esecutiva, nella personalizzazione avanzata e nella riduzione degli sprechi.
Per affrontare questo complesso ambito, il progettista deve integrare fin dalle prime fasi aspetti architettonici, strutturali, impiantistici e prestazionali in un sistema costruttivo altamente ingegnerizzato.
Crescita del mercato e sostenibilità ambientale
Il mercato delle costruzioni in legno ha conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni. In Italia, circa il 7-8% delle nuove abitazioni sono realizzate in legno, un dato che riflette un interesse crescente per l’efficienza energetica e l’impatto ambientale. Secondo i dati di FederlegnoArredo, il comparto delle costruzioni in legno in Italia vale oltre un miliardo di euro, spinto anche dagli incentivi fiscali e dalla crescente sensibilità verso la sostenibilità.
Un edificio in legno può contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 non solo perché il materiale è riciclabile e rinnovabile, ma anche perché ha una capacità unica di “stoccare” anidride carbonica. Un metro cubo di legno, infatti, evita l’emissione di circa una tonnellata di CO2 rispetto a materiali tradizionali come il calcestruzzo.
Il quadro normativo
In Europa, le direttive sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD) e il pacchetto “Fit for 55” sostengono la transizione verso soluzioni costruttive a basso impatto ambientale. In Italia, norme come la UNI EN 14081 e il D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) regolano la progettazione e l’utilizzo del legno strutturale, garantendo sicurezza e qualità nel rispetto delle regole sismiche e ambientali. Gli architetti devono confrontarsi con normative sempre più stringenti, ma anche con strumenti che incentivano la scelta di materiali sostenibili.
Scelta del sistema costruttivo: confronto tra telaio e X-LAM
Il primo step nella gestione del progetto è la selezione della tecnologia costruttiva più adatta. Le due principali alternative sono: il sistema a telaio (Platform Frame) e il sistema a pannelli X-LAM. Il sistema a telaio (Platform Frame) è ideale per edifici residenziali singoli o di piccole dimensioni, il sistema a telaio combina leggerezza e flessibilità progettuale. Consiste in una struttura leggera fatta di montanti e traversi in legno, completata con pannelli isolanti e di irrigidimento. I progetti architettonici possono spingersi verso design complessi senza compromettere la stabilità.
Il sistema a pannelli X-LAM (legno lamellare a strati incrociati) è invece indicato per edifici multipiano e strutture più complesse. Questo sistema garantisce una maggiore robustezza, isolamento acustico superiore e un comportamento eccellente in caso di eventi sismici. La stabilità strutturale dei pannelli X-LAM consente geometrie complesse (sbalzi bidirezionali, fori estesi) e altezze fino a 9 piani con precisione millimetrica grazie alla prefabbricazione. Inoltre, in zone con estati torride (es. Pianura Padana), l’X-LAM offre maggiore inerzia termica, riducendo il fabbisogno di raffrescamento.
La selezione tra tecnologia a telaio e X-LAM è dunque il primo snodo critico. La scelta dipende da vari fattori, tra cui la destinazione d’uso, il numero di piani e il clima della zona in cui si realizza l’edificio.
Una volta stabilite le caratteristiche degli elementi costruttivi, si procede con un’analisi strutturale preliminare. Questa fase necessita della stretta collaborazione con un ingegnere strutturista e include: la definizione degli schemi statici della struttura, l’identificazione delle strutture portanti verticali e degli orizzontamenti, la scelta della tipologia di copertura e delle eventuali soluzioni antisismiche.
Organizzazione delle partizioni interne e gestione degli impianti
Nel caso di edifici in legno la disposizione delle pareti interne deve essere attentamente pianificata per evitare modifiche in corso d’opera, che potrebbero incidere sui costi e sui tempi di realizzazione. È essenziale prevedere in anticipo lo spazio necessario per impianti elettrici, idraulici e di ventilazione meccanica controllata (VMC). Ugualmente importante definire carichi e geometrie prima di scegliere spessori e materiali (es. evitare di progettare solai in X-LAM senza verificare l’impatto degli impianti). La progettazione deve quindi prevedere l’installazione di:
- contropareti per il passaggio degli impianti (5-7,5 cm minimo)
- cavedi verticali per colonne di scarico
- spazi per VMC e relative canalizzazioni: intercapedini tecniche da 8-10 cm per ospitare le condotte senza ridurre l’isolamento acustico
- alloggiamenti per cassonetti e sistemi oscuranti
E deve inoltre evitare attraversamenti nelle pareti portanti: meglio allineare gli impianti alle partizioni non strutturali.
Buone pratiche per una progettazione ottimale
Per garantire la qualità del progetto architettonico di una casa in legno, è fondamentale rispettare alcune regole fondamentali:
- mantenere un approccio sistematico e sequenziale alla progettazione dando priorità alla fase preliminare: definire stratigrafie, sistemi costruttivi e impianti prima di disegnare i volumi
- collaborazione interdisciplinare: coinvolgere termotecnici e strutturisti per evitare revisioni multiple
- formazione continua: approfondire tecnologie emergenti (es. legno lamellare ibrido, connettori a secco)
- simulazioni prestazionali: utilizzare software BIM per verificare ponti termici e compatibilità tra materiali
- stabilire un budget preventivo realistico (spesso ≥ 2.000 €/m² per un “chiavi in mano” comprensivo di finiture – esclusi fondazioni e terreno) e verificare man mano la compatibilità con le soluzioni architettoniche e impiantistiche prescelte.
Quando si progetta una casa in legno, ci sono alcuni errori che vengono commessi frequentemente e che sarebbe meglio evitare fin dall’inizio. Uno dei problemi più ricorrenti riguarda l’altezza dei solai: spesso vengono dimensionati troppo bassi, senza considerare adeguatamente lo spazio necessario per gli scarichi e gli impianti, specialmente quando si opta per un sistema di riscaldamento a pavimento che richiede spessori maggiori.
Un altro aspetto sottovalutato è la progettazione dei serramenti. Molti progettisti non tengono conto dell’ingombro dei cassonetti per le tapparelle o dei sistemi frangisole, trovandosi poi costretti a modificare il progetto aumentando lo spessore delle pareti interne, con conseguenti disagi e costi aggiuntivi. Infine, ma non meno importante, c’è la questione della gestione dell’umidità, un elemento cruciale nelle costruzioni in legno. Spesso vengono trascurati dettagli fondamentali come i giunti a terra e le sigillature tra i pannelli, che invece richiedono particolare attenzione per garantire la durabilità e il comfort abitativo della struttura.
Un’ultima osservazione riguarda la logistica. La filiera del legno in Italia presenta criticità da gestire, ad esempio la distanza dai produttori. In Sicilia o Calabria, il trasporto di X-LAM dalla Germania può aumentare i costi del 15-20%. Valutare alternative come il telaio, ridurre spessori non strutturali (ad esempio, contropareti) e preferire materiali locali (ad esempio, abete vs larice importato).
In sintesi, la progettazione di edifici in legno richiede rigore metodologico e un approccio integrato. L’architetto deve essere un regista capace di orchestrare competenze diverse e di gestire contemporaneamente aspetti tecnici, prestazionali ed economici, mantenendo sempre una visione d’insieme del processo costruttivo.
I due sistemi costruttivi principali sono la tecnologia a telaio (platform frame) e la tecnologia X-LAM (pannelli in legno massiccio incrociato).
La scelta dipende da vari fattori: zona climatica, comportamento termico estivo, numero di piani, regolarità della struttura, logistica e disponibilità locale dei materiali.
Il costo medio si aggira tra i 2.000 e i 2.200 euro/mq per la parte in legno, comprensivo di finiture e impianti, ma escluso il terreno e le fondazioni.
È essenziale definire in anticipo sistema costruttivo, stratigrafie, spessori, impianti e dettagli dei serramenti per evitare modifiche in corso d’opera e problemi di budget.
Bisogna calcolare accuratamente spessori delle pareti, contropareti per impianti, cassonetti per oscuranti e verificare la compatibilità con le dimensioni dei locali e dei serramenti.
Occorre rispettare le regole della buona progettazione: struttura secondaria parallela alla pendenza, luci compatibili con le capacità dei materiali, attenzione a sbalzi e dettagli costruttivi per evitare problemi statici e termici.