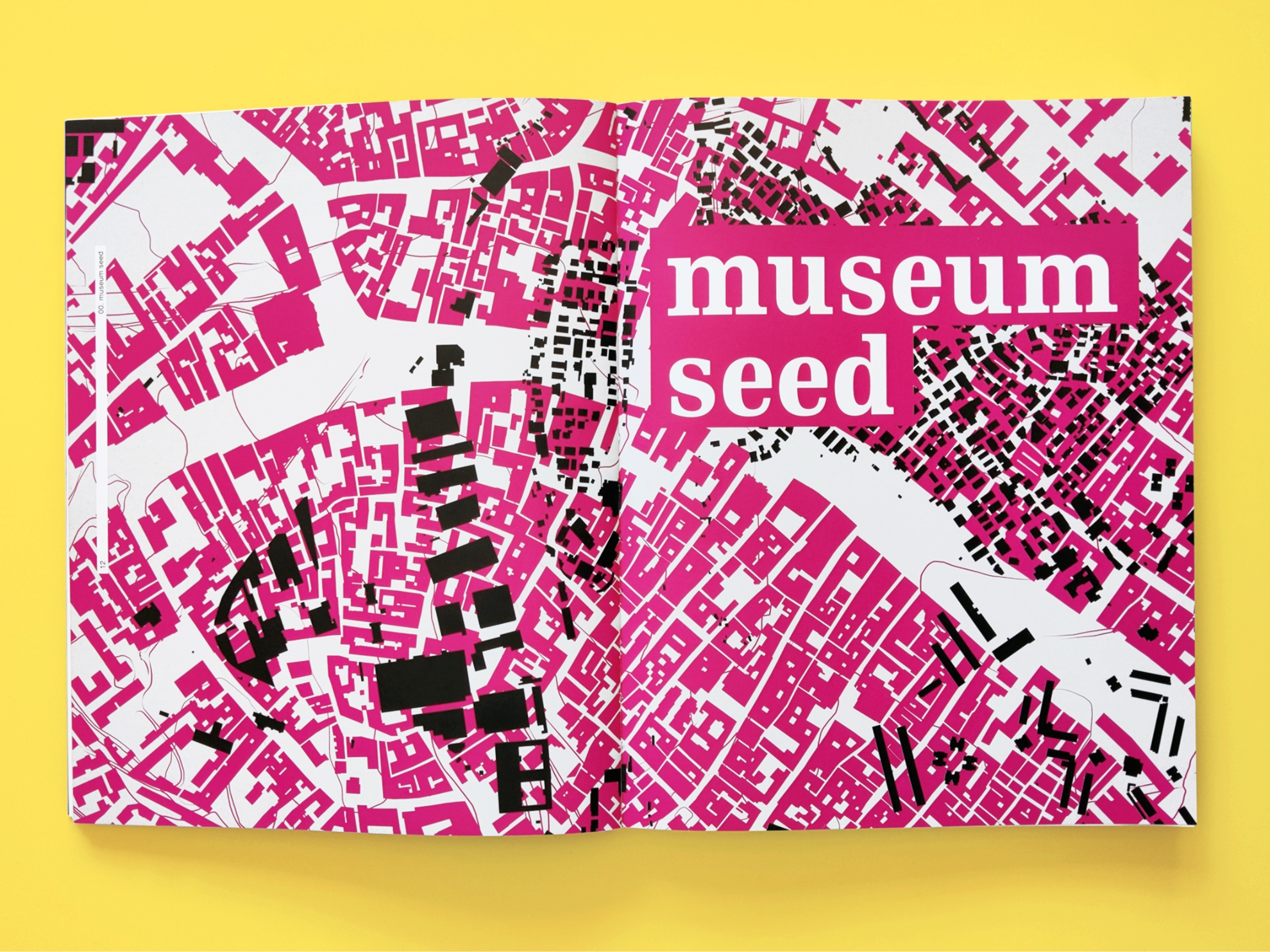La luce non è semplicemente uno strumento tecnico per rendere visibile l’architettura: è materia viva, emozione palpabile, linguaggio silenzioso che trasforma gli spazi e costruisce identità. L’approccio contemporaneo alla progettazione illuminotecnica richiede agli architetti di superare la logica quantitativa dei lux e dei lumen per abbracciare la dimensione qualitativa della luce, quella che parla direttamente alle emozioni, che crea atmosfere e che definisce il carattere degli ambienti abitati. L’esperienza di Foscarini, azienda che da oltre quarant’anni esplora le possibilità espressive della luce decorativa, offre una prospettiva preziosa su come il design illuminotecnico possa diventare strumento progettuale per trasformare gli spazi e costruire narrazioni.
La luce come materiale primario dell’esperienza
La luce possiede una caratteristica unica nel panorama dei materiali a disposizione del progettista: è contemporaneamente materia, informazione e sensazione. Fa apparire le cose, trasmette calore, crea benessere o disagio, agisce direttamente sul sistema limbico dove non esiste il linguaggio razionale ma solo le sensazioni pure. Questa peculiarità rende la luce il materiale più potente per chi progetta esperienze spaziali, superando di gran lunga le possibilità espressive dei materiali tradizionali.
Prima ancora di parlare di apparecchi, il competitor principale e inarrivabile è il sole, che sorge ogni mattina, illumina gratuitamente, scalda, crea buonumore e poi scompare lasciando lo spazio alla notte. Questa luce naturale possiede una potenza che le permette di far vibrare le molecole presenti nell’aria, che diventano ripetitori di luce creando un’illuminazione avvolgente proveniente dall’infinito. Quando il sole tramonta, improvvisamente il mondo esterno scompare nel buio e la realtà si ricrea all’interno degli spazi abitati, dove piccoli soli artificiali costruiscono nuovi universi in scala ridotta. Da questo confronto nasce una distinzione fondamentale tra approccio tecnicistico e approccio progettuale consapevole, tra quantità e qualità della luce. La quantità è misurabile: 150-200 lux per terra negli ambienti di lavoro, 500 lux sulle scrivanie, indici di resa cromatica per i negozi di tessuti. La qualità invece non è misurabile con strumenti: parla alla cultura individuale, alle esperienze personali, alle memorie emotive. Non si può assegnare un voto da uno a dieci alla bellezza di un oggetto, ma si può costruire uno scenario narrativo che ne restituisca il valore culturale e il significato profondo.
La scelta degli oggetti illuminanti che entreranno a far parte degli spazi vissuti costituisce una responsabilità progettuale che va oltre la funzionalità immediata. Ogni lampada diventa parte dell’identità dello spazio e, per estensione, di chi lo abita: qualsiasi ambiente diventa “casa propria” quando è illuminato dalle lampade scelte personalmente. Questa responsabilità della scelta si sta pericolosamente diluendo nella pratica contemporanea, dove troppo spesso la luce viene considerata una commodity, qualcosa di cui c’è bisogno da risolvere pragmaticamente senza riflessione progettuale. L’atteggiamento “mettiamo anche la luce” rappresenta un impoverimento delle possibilità espressive dell’architettura, che perde l’opportunità di utilizzare il materiale comunicativamente più potente a sua disposizione. La sera, quando si accende la lampada, l’80% delle informazioni visive che riceviamo viaggia sulle onde luminose emesse da quella fonte. Se quella fonte è stata scelta consapevolmente, istintivamente ci sentiamo a casa: il semplice gesto di accendere la luce diventa un rituale di riappropriazione dello spazio personale, un “bentornato” silenzioso ma potente.
L’impoverimento progettuale degli spazi contemporanei
La tendenza contemporanea a relegare le fonti luminose sulle superfici, attraverso sistemi integrati nell’architettura che garantiscono la quantità di luce necessaria ma rinunciano alla presenza nello spazio delle lampade, sta impoverendo drammaticamente la ricchezza espressiva degli ambienti. Una lampada posizionata nello spazio, a una certa altezza, non fornisce solo illuminazione ma crea un ritmo, interpreta lo spazio come le note su uno spartito musicale, crea gerarchie e relazioni.
L’esempio del punto luce centrale nelle stanze italiane illustra perfettamente questo impoverimento: posizionare una lampada all’incrocio delle diagonali della stanza crea un blocco percettivo che impedisce di leggere la ricchezza e la varietà dello spazio. La stessa lampada spostata in un angolo, meglio se nell’angolo opposto rispetto all’ingresso, trasforma radicalmente la lettura dello spazio, creando un’interpretazione che diventa firma progettuale dell’architetto. La progressiva scomparsa di lampade basse o appoggiate elimina la possibilità di creare ritmi di lettura dello spazio, di costruire effetti più caldi e accoglienti nei punti destinati alla relazione tra le persone, alla lettura, alla conversazione. Ogni altezza di posizionamento della luce costruisce una diversa atmosfera e suggerisce diversi usi dello spazio: perdere questa articolazione significa perdere uno degli strumenti più potenti per costruire ambienti ospitali e caratterizzati.
La luce e la costruzione culturale dello spazio
L’architettura religiosa offre esempi paradigmatici di come la luce sia stata utilizzata per materializzare concetti culturali profondi. Il romanico, con le sue strutture potenti e le bucature piccole posizionate in alto, creava raggi di luce che cercavano il fedele dall’infinito, costruendo la rappresentazione di un Dio lontano, potente, che osserva dall’alto. Le chiese gotiche, con l’evoluzione delle tecniche costruttive che permisero colonne più sottili e vetrate ampie e colorate, rappresentarono una rivoluzione teologica oltre che architettonica: un Dio più gioioso, più accessibile, che si manifesta attraverso la luce colorata che arriva fino al piano di calpestio.
Le moschee, con il loro sistema di illuminazione piatto che lascia intravedere un piano ulteriore oltre i sette veli coranici, materializzano un concetto di divinità radicalmente diverso: un Dio che è “più vicino della vena giugulare”, presente più che lontano, avvolgente più che giudicante. La forma stessa della moschea, più simile a una nicchia che accoglie che a una navata che dirige verso l’altare, si esprime attraverso una qualità di luce completamente differente da quella delle chiese cristiane. Questi esempi dimostrano che la luce non è mai neutra, ma costruisce sempre significati culturali precisi. La sfida per l’architetto contemporaneo è acquisire consapevolezza di questo potere costruttivo della luce per utilizzarlo intenzionalmente nella progettazione degli spazi abitativi, commerciali e pubblici.
La libertà come fondamento dell’innovazione
Il modello produttivo di Foscarini, fondato sul principio di non produrre nulla direttamente ma di orchestrare una rete di artigiani e piccole manifatture specializzate, rappresenta un paradigma illuminante per comprendere le possibilità dell’industria italiana contemporanea. Questa scelta, nata per necessità negli anni ‘80 quando l’azienda lavorava su progetti custom di grande scala per il Medio Oriente, si è rivelata l’asset strategico fondamentale: la libertà da vincoli produttivi permette di selezionare progetti per il loro valore identitario piuttosto che per la compatibilità con i reparti produttivi. Non avere macchine, torni, stampatrici o tecnologie proprietarie da ammortizzare significa poter valutare ogni progetto esclusivamente per la sua capacità di arricchire l’identità del brand, di aggiungere un tassello al puzzle di personalità che costituisce il catalogo Foscarini. Questa libertà comporta anche responsabilità: ogni volta che si seleziona un’idea si sta scegliendo un pezzo della propria immagine, si sta definendo chi si è agli occhi del pubblico.
Il rapporto con i fornitori diventa un dialogo tra chi ha un’idea chiara di dove vuole arrivare ma non di come arrivarci, e chi conosce profondamente una tecnologia o un materiale ma non sa necessariamente cosa farne oltre gli usi consolidati. Quando si crea un punto di incontro tra queste due competenze, nasce l’innovazione vera. Il principio del “non si può fare” diventa un segnale positivo: se qualcosa non è mai stato fatto prima, si sta percorrendo una strada potenzialmente innovativa. L’importante è non fermarsi alla prima risposta negativa, ma chiedere perché non si può fare, comprendere il blocco tecnico, tornare con proposte alternative fino a quando, per stanchezza o per volontà di dimostrare che davvero non si può fare, si prova e si scopre che si può fare.
La collaborazione con i designer non segue il modello tradizionale dove il designer consegna un’idea che l’azienda industrializza, ma prevede uno sviluppo a quattro mani dove Foscarini seleziona quali aspetti dell’idea iniziale meritano di essere sviluppati e potenziati. Questo approccio permette di fare in modo che ogni prodotto sia contemporaneamente espressione della visione del designer e tassello coerente dell’identità Foscarini. Non è sempre facile, perché richiede fiducia reciproca e disponibilità a mettere in discussione le proprie certezze iniziali, ma quando funziona produce risultati che superano le aspettative di entrambe le parti. Il caso più emblematico di questa collaborazione produttiva è quando Rodolfo Dordoni, di fronte al prodotto finito dopo mesi di sviluppo congiunto, dichiarò “non mi sarei mai immaginato una cosa così bella”. Significa che l’idea iniziale aveva un potenziale enorme, ma che solo lavorandoci insieme e spremendone tutte le possibilità si è riusciti a farlo emergere completamente, creando qualcosa che ha superato anche le aspettative del suo autore.
La base artigianale del design italiano
Il professor Stefano Micelli di Ca’ Foscari, nel suo libro “Futuro Artigiano” premiato con il Compasso d’Oro, ha dimostrato da economista che la base del design italiano è l’artigianalità delle imprese a cui ci si rivolge per risolvere i problemi progettuali: aziende spesso familiari con 20-50 persone, ognuna delle quali lavora con le proprie mani e la propria sensibilità. Questo sistema è specificamente italiano, non per presunzione di superiorità ma per contingenze storiche e culturali. In Germania esistono grandi aziende industriali o piccoli artigiani individuali, ma non quella fascia intermedia di “fabbriche artigiane” capaci di produrre centinaia o migliaia di pezzi all’anno mantenendo intervento manuale qualificato. In Francia esistono artigiani individuali ma non strutture organizzate con quella scala. Solo in Italia esiste un ecosistema di aziende che possono gestire commesse significative senza rinunciare alla componente manuale e alla sensibilità dell’intervento umano. Questa alchimia particolare tra capacità di immaginare oggetti densi di significato e capacità artigianale di realizzarli senza richiedere impianti industriali da milioni di pezzi all’anno costituisce un patrimonio di inestimabile valore.
Casi studio: materiali e sperimentazioni
La carta washi, patrimonio dell’umanità UNESCO, rappresenta un esempio perfetto di come materiali tradizionali possano trovare nuove applicazioni nell’illuminazione contemporanea. Questa carta ottenuta dalla triturazione e cottura di arbusti, stesa su telai non piani attraverso tecniche ancora parzialmente misteriose, offre caratteristiche uniche: superficie non lucida, traslucenza controllata, calore visivo. Il progetto sviluppato con Luca Nichetto e Nendo per la lampada Kurage utilizza questa carta per creare una luce particolarmente calda e avvolgente, con una base in legno che sostiene la componente tecnica ma serve anche a creare l’area di luce bassa nello spazio, elemento sempre più raro negli allestimenti contemporanei.
Il progetto Mite di Marc Sadler rappresenta invece un caso di ribaltamento logico: tradizionalmente le lampade hanno una struttura portante che distribuisce l’elettricità e sostiene un diffusore decorativo. L’idea di Sadler fu di utilizzare materiali compositi per creare un diffusore che fosse contemporaneamente elemento strutturale, eliminando la distinzione tra funzione e forma. Due anni di sviluppo furono necessari per risolvere il problema di mantenere l’esoscheletro in Kevlar (o carbonio nella versione nera) nella posizione corretta durante il processo di cottura in forno sotto vuoto. Il risultato, premiato con il Compasso d’Oro 2001, venne definito da Gillo Dorfles “una sintesi delle possibilità tecnologiche a servizio di un effetto finale”.
La lampada Allegro dell’Atelier Oï affronta invece la sfida di far passare la luce attraverso materiali non traslucidi: bacchette che devono essere posizionate alternandole per creare spazi attraverso cui la luce emerge per riflessione. La complessità progettuale risiede nell’utilizzo della gravità come principio compositivo: le bacchette devono fermarsi naturalmente con il proprio peso formando un volume che in realtà non esiste fisicamente, creato dall’aggregazione di elementi singoli. Questo progetto introduce anche la dimensione sonora: il movimento dell’aria fa vibrare le bacchette creando suoni delicati, aggiungendo alla componente visiva una dimensione acustica.
La lampada Rituals, con il suo disco in materiale traslucido montato su un cerchio armonico che gli fa assumere una forma naturale, esemplifica perfettamente questo approccio. Una singola fonte luminosa fornisce contemporaneamente luce riflessa verso il basso (illuminazione concentrata sul tavolo) e luce diffusa verso l’alto attraverso il materiale traslucido (illuminazione generale dell’ambiente). L’effetto, quando il prototipo fu acceso per la prima volta, superò le aspettative proprio perché la luce riesce sempre a sorprendere, a “prenderti alla schiena” come dice Urbinati. La qualità del materiale, con la sua capacità di bilanciare riflessione e trasmissione, crea un risultato che sulla carta si immaginava ma che nella realtà si è rivelato molto più forte e suggestivo del previsto.
La quantità di luce è misurabile oggettivamente: lux sulla superficie, indice di resa cromatica, temperature di colore. È regolata da normative che stabiliscono valori minimi per diverse attività. La qualità invece non è misurabile: riguarda come la luce parla alla cultura individuale, alle esperienze personali, alle emozioni. Si progetta per la qualità scegliendo tipologia di sorgenti, posizioni nello spazio, altezze, temperature di colore e soprattutto oggetti illuminanti che costruiscono narrazioni coerenti con l’identità dello spazio.
Le lampade posizionate nello spazio creano ritmi di lettura, interpretano lo spazio come note su uno spartito, costruiscono gerarchie e suggeriscono usi. Una lampada centrale blocca la percezione dello spazio; spostata in un angolo lo interpreta. Lampade basse o appoggiate creano atmosfere più calde nei punti destinati alla relazione tra persone. L’integrazione nelle superfici fornisce quantità di luce ma impoverisce la ricchezza espressiva, eliminando la possibilità di articolare lo spazio attraverso diverse altezze e posizioni delle sorgenti.
Il romanico utilizzava bucature piccole in alto per creare raggi che cercavano il fedele dall’infinito, rappresentando un Dio lontano e potente. Il gotico, con vetrate ampie e colorate che arrivano in basso, rappresentò un Dio più gioioso e accessibile. Le moschee utilizzano illuminazione piatta che lascia intravedere piani ulteriori, materializzando un Dio “più vicino della vena giugulare”. Questi esempi dimostrano che la luce non è mai neutra ma costruisce sempre significati culturali precisi.
Foscarini non produce direttamente ma orchestra una rete di artigiani e piccole manifatture specializzate. Questo modello, nato per necessità, garantisce libertà totale da vincoli produttivi: ogni progetto può essere selezionato per il suo valore identitario piuttosto che per compatibilità con reparti da alimentare. Non avere tecnologie proprietarie da ammortizzare significa poter valutare progetti esclusivamente per la capacità di arricchire l’identità del brand. La sfida diventa creare i problemi e poi trovare chi li risolve. “Non si può fare” è infatti spesso un buon segnale: significa che si sta percorrendo una strada non battuta, potenzialmente innovativa. L’importante è non fermarsi alla prima risposta negativa: chiedere perché non si può fare, comprendere il blocco tecnico, tornare con proposte alternative. Spesso per stanchezza o per dimostrare che davvero non si può, si prova e si scopre che si può. Il caso della lampada Mite mostra come il risultato finale sia emerso da ciò che i tecnici consideravano un “errore”.
La semplicità nell’illuminazione non significa facilità di realizzazione ma purezza espressiva: eliminare tutto ciò che è superfluo per permettere una comprensione immediata ed emozionale che precede il raziocinio. Foscarini lavora specificamente per il primo colpo d’occhio, creando lampade che catturano l’attenzione e l’emozione prima ancora che intervenga l’analisi razionale. La conoscenza tecnica può arricchire successivamente l’apprezzamento, ma non deve essere condizione preliminare per l’emozione. Questa scelta rende le lampade accessibili emotivamente a tutti, riservando l’approfondimento tecnico a chi vuole comprendere i processi realizzativi. L’obiettivo è che le caratteristiche personalizzanti di ogni prodotto siano immediatamente leggibili e forti, costruendo un catalogo dove ogni pezzo porta una voce distinta riconoscibile al primo sguardo.
L’economista Stefano Micelli ha dimostrato che la base del design italiano è l’esistenza di “fabbriche artigiane”: aziende con 20-50 persone capaci di produrre centinaia/migliaia di pezzi all’anno mantenendo intervento manuale qualificato. Questa fascia intermedia esiste solo in Italia e questa alchimia tra capacità di immaginare oggetti densi di significato e competenza artigianale per realizzarli senza impianti da milioni di pezzi costituisce la specificità italiana.