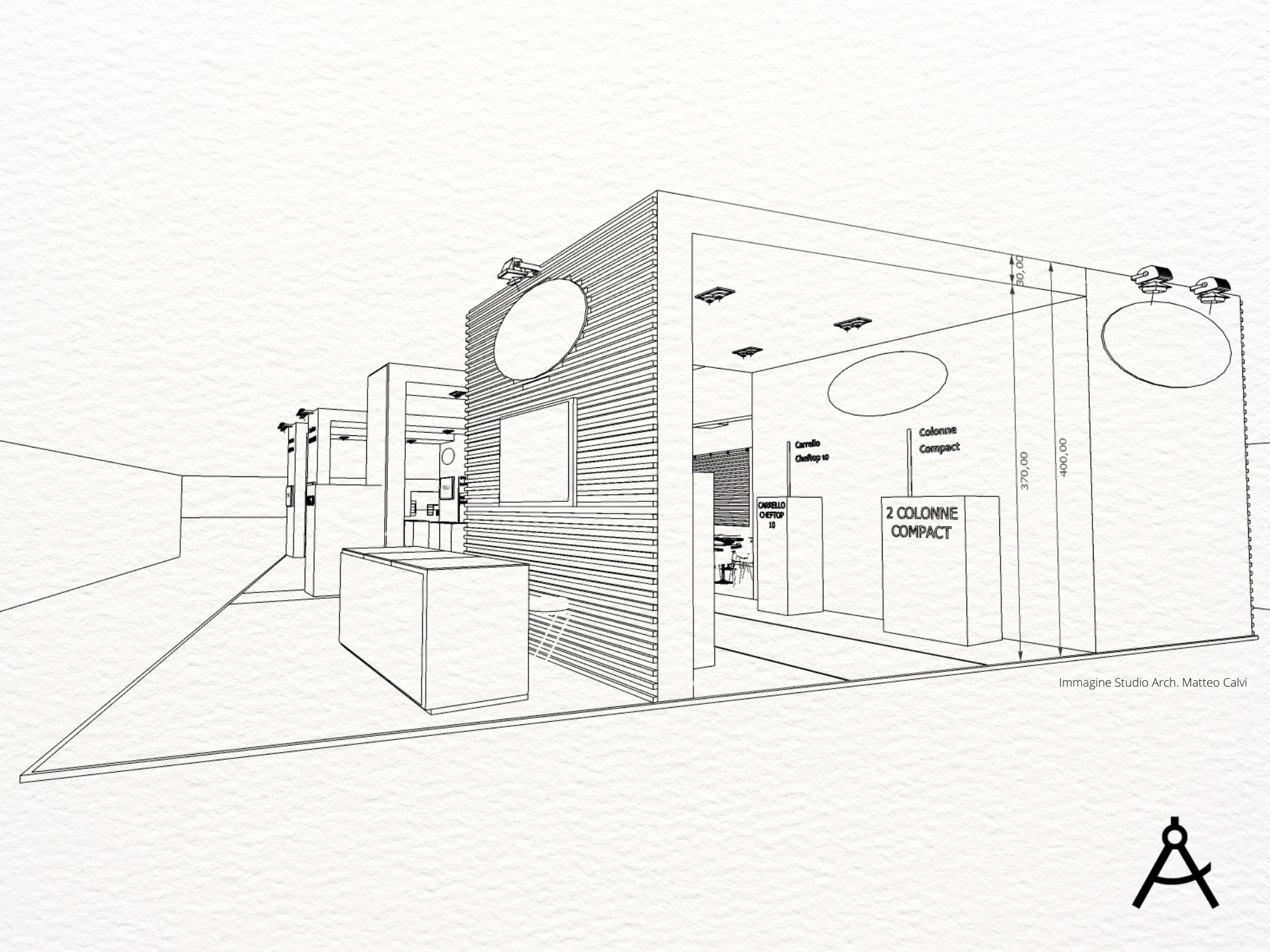Saper comunicare non basta, occorre imparare a gestirsi nelle relazioni, integrando competenze tecniche con consapevolezza, empatia e assertività.
Il percorso formativo proposto dal dottor Giorgio Cozzi – coach, trainer, psicologo ed esperto di HR management – si inserisce nel ciclo “How to do | Eccellenza per gli architetti” e accende il focus sui fondamentali della comunicazione. Il seminario affronta vari aspetti: dalle interferenze e distorsioni percettive, all’intelligenza emotiva come leva per decisioni efficaci, negoziazione e conduzione di riunioni ad alto impatto.
I fondamentali della comunicazione: oltre le parole
La comunicazione può avvenire secondo due modalità fondamentali che producono risultati radicalmente diversi. La comunicazione a una via, tipicamente unidirezionale, offre il vantaggio della velocità ma presenta lo svantaggio di non sapere cosa succede dall’altra parte: il messaggio passa o non passa, viene compreso o frainteso, suscita interesse o noia, senza che l’emittente possa saperlo.
La comunicazione a due vie, caratterizzata dal feedback continuo, aggiunge invece la capacità fondamentale di capire se l’interlocutore ha compreso. Presentare un progetto per quaranta minuti senza che nessuno intervenga non rappresenta una comunicazione efficace. La tentazione del monologo che soddisfa l’ego del progettista deve essere combattuta: non si comunica per se stessi ma per gli altri.
Il codice semantico costituisce il secondo fondamentale della comunicazione: le parole trasportano messaggi il cui significato deve essere univoco tra chi parla e chi ascolta. Ad esempio, “batteria” assume significati differenti se usata in un negozio di articoli elettrici, in un’autorimessa o in un negozio di strumenti musicali. Il contesto regola il significato, e se chi parla usa un codice che l’interlocutore non capisce, la comunicazione fallisce.
Nel mondo dell’architettura esiste un gergo tecnico che tra professionisti funziona perfettamente, ma l’attività professionale comporta il confronto con figure diverse (clienti, fornitori, partner, consulenti), ciascuna con il proprio linguaggio. Usare le parole appropriate, renderle comprensibili alla persona che ascolta, guardare sempre al fine ultimo (che l’altro capisca) rappresenta un requisito di eccellenza comunicativa imprescindibile.
Le interferenze: il rumore che distorce il messaggio
Le interferenze rappresentano ostacoli che compromettono la trasmissione e ricezione corretta dei messaggi, articolandosi in tre tipologie con impatti differenti sul risultato finale.
Le interferenze meccaniche costituiscono la forma più evidente: il rumore ambientale, la linea telefonica disturbata, un colpo di tosse al momento sbagliato. Capita che una parola essenziale sfugga, e se quella parola è “NON”, l’intera frase cambia completamente significato. Nella società contemporanea caratterizzata dall’intelligenza artificiale e dalla moltiplicazione degli stimoli, il rumore è lievemente aumentato, interferendo sempre più sul messaggio che si vuole comunicare e sulla ricezione dei messaggi altrui.
Le interferenze semantiche derivano invece dall’uso di un linguaggio che non trasferisce il messaggio desiderato ma un altro, perché il codice non è stato tradotto correttamente o non è stato inteso come si voleva. Questo tipo di interferenza si verifica costantemente quando professionisti tecnici comunicano con clienti privi di competenze specialistiche, usando termini tecnici senza spiegarli o dando per scontate conoscenze che l’interlocutore non possiede. Le interferenze emotive o psicologiche rappresentano la categoria più insidiosa e impattante. Lo stato d’animo regola profondamente la capacità di comunicare e comprendere: il retropensiero che occupa la mente mentre si comunica rappresenta un’interferenza devastante che impedisce la presenza autentica.
Il significato come misura del successo comunicativo
Il fine ultimo della comunicazione non è parlare eloquentemente ma essere compresi: se l’interlocutore ha capito quello che si voleva dire e lo conferma attraverso il feedback, la comunicazione è riuscita. Se non c’è feedback, o si è capito male, o non si è capito affatto, la comunicazione è fallita indipendentemente dalla bellezza delle parole usate. Questo principio ribalta la prospettiva narcisistica: parla come vuoi, ma se l’altro non ha capito non hai ottenuto risultati.
Nei progetti complessi, fraintendimenti e incomprensioni sono la norma e richiedono gestione consapevole. La percezione costituisce un ulteriore elemento critico: un punto di vista è sempre il proprio punto di vista, che può differire radicalmente da quello dell’interlocutore. Quando qualcuno afferma “questo progetto è bello”, cosa significa esattamente “bello”? Solo specificandone il contenuto, si può verificare se effettivamente c’è accordo. Nel confronto tra architetti, fornitori e clienti capita costantemente che ci sia ambiguità su qualche aspetto: dove c’è ambiguità probabilmente esistono punti di vista diversi che devono essere esplicitati.
I tre canali della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale
La comunicazione effettiva deriva dall’insieme di tre canali differenti che contribuiscono in misura diversa al risultato finale. La comunicazione verbale si compone delle parole effettivamente pronunciate, la comunicazione non verbale include gesti, posture, espressioni facciali, la comunicazione paraverbale comprende tono, impressione, ritmo, armonia, pause, picchi e cadute vocali. La domanda cruciale riguarda quale dei tre canali impatti maggiormente sui risultati.
Le ricerche scientifiche forniscono una risposta precisa: la comunicazione verbale vale solo il 7% della comprensione e dell’accoglimento del messaggio da parte degli interlocutori. Nonostante l’attenzione ossessiva spesso dedicata alla scelta delle parole, queste influenzano minimamente il risultato comunicativo complessivo. La comunicazione non verbale risulta invece al primo posto, con 10-12 punti percentuali di differenza rispetto a quella paraverbale, perché la vista è l’organo che fornisce immediatamente un insieme di informazioni che, una volta ricevute, vengono acquisite subito.
Questo significa che nel mondo dell’architettura, dei progetti, della continua comunicazione con clienti, fornitori, colleghi, il contenuto verbale conta molto ovviamente, ma conta relativamente poco rispetto agli altri due canali. La comunicazione non verbale è quella che viene percepita immediatamente e visceralmente. Questi concetti devono essere messi “nel taschino” e applicati consapevolmente in tutte le interazioni professionali.
Dalla comunicazione alla relazione: l’empatia come differenza
La relazione rappresenta qualcosa di più profondo rispetto alla comunicazione: mentre comunicare significa trasferire informazioni, relazionarsi implica stabilire un rapporto tra persone. Questo comporta fiducia, arricchimento reciproco, empatia. La differenza fondamentale risiede nel fatto che la comunicazione è un fatto tecnico, mentre la relazione è un fatto sociale che coinvolge almeno due punti di vista e include sentimenti ed emozioni che vanno oltre il mero scambio informativo. Tre principi fondamentali regolano la relazione.
Primo: non si può non comunicare. Se si è in relazione (almeno in due), si comunica anche stando zitti. Il silenzio comunica, anzi comunica più che il parlare. Un progetto che interessa molto e il cliente che non dà alcuna risposta sta comunicando qualcosa di molto preciso. Secondo: si trasmette sempre contemporaneamente un contenuto e una relazione.
Terzo principio: se si parla di relazioni senza considerare le emozioni, si taglia fuori una parte della realtà. Le emozioni emergono da qualcosa che si prova e regolano la comunicazione. La coerenza tra comunicazione verbale e non verbale diventa quindi cruciale: dire “questo progetto mi ha dato un immenso piacere” con tono piatto e volto inespressivo trasmette una contraddizione stridente che l’interlocutore percepisce immediatamente.
L’intelligenza emotiva: consapevolezza e autocontrollo
Secondo Daniel Goleman, l’intelligenza emotiva rappresenta la capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri per motivare se stessi e per gestire bene le emozioni interiormente e nei rapporti interpersonali. Gli ingredienti fondamentali sono quattro: consapevolezza di sé, autocontrollo, empatia e abilità sociali (assertività).
La consapevolezza di sé significa sapere di sapere, sentire cosa si prova veramente, essere presenti a se stessi. Quante volte sul lavoro si è effettivamente presenti a se stessi? La presenza è diversa dall’essere travolti da impegni e stimoli: vuol dire sapere cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo e volerlo fare consapevolmente nonostante i limiti esistenti. L’autocontrollo rappresenta invece la partita più difficile nella società contemporanea, che mostra scarsissimo autocontrollo generale. L’autocontrollo dipende dall’amigdala, piccolo organo doppio situato nel cervello che regola le risposte istintuali. Di fronte a stimoli, l’amigdala precede le risposte logiche, producendo reazioni immediate finalizzate a liberarsi dall’ansia accumulata piuttosto che a gestire consapevolmente la situazione. Quando arriva uno stimolo nocivo che interferisce e non è gradito, scatta velocemente una risposta istintuale. La risposta consapevole richiederebbe invece di fermarsi un attimo, considerare che forse la situazione si può fronteggiare in altro modo, cercare alternative. Ma nella società contemporanea raramente si risponde prendendosi tutto il tempo necessario per porsi in modo educato, produttivo, efficace. Il più delle volte si agisce per istinto: vengo colpito e reagisco. Questa modalità, pur comprensibile, non è valida dal punto di vista relazionale e professionale.
Empatia e assertività: costruire relazioni sane
L’empatia costituisce il terzo ingrediente dell’intelligenza emotiva e rappresenta la base sulla quale si costruisce l’assertività. L’empatia non è debolezza ma forza: significa comprendere profondamente la posizione altrui senza necessariamente condividerla, creando lo spazio per una risposta costruttiva anziché distruttiva.
Il concetto di “poetica” emerge come valore aggiunto: quando tutto quello che si fa ha un significato che gli altri colgono, si raggiunge un livello artistico che va oltre i fatti materiali, oltre i processi procedurali, oltre i vincoli normativi. La poetica presuppone che si sia competenti su processi, norme e cose materiali, e aggiunge il valore immateriale che rappresenta la ragione per cui poi qualcuno sceglie proprio quel progettista. Elaborare i progetti con un po’ di poesia rappresenta un approccio che può sembrare retorico ma in realtà è profondamente efficace.
L’assertività rappresenta l’abilità sociale di dire le cose senza offendere l’altro, senza prevaricare, affermando se stessi senza annullare l’interlocutore. Non è banale: richiede abilità che si sviluppa attraverso formazione, confronto e dialogo.
Zone d’ombra e distorsioni dell’intelligenza emotiva
Anche l’intelligenza emotiva presenta zone d’ombra che possono compromettere le relazioni professionali. L’ambizione priva di regole rende difficilissimo gestire emotivamente il confronto con qualcuno la cui ambizione va oltre misura. La perdita della considerazione per gli altri (“quelli non contano nulla”) elimina metà delle possibilità di costruire relazioni efficaci. Il ragionevole bisogno di riconoscimenti diventa patologico quando si trasforma in necessità di essere continuamente osannati, adulati, incensati. La convinzione della propria perfezione (“io sono io”) rappresenta un’altra zona d’ombra devastante: quando si è convinti di essere il meglio, si chiude la comunicazione e si spegne la relazione. Accendere tutta la luce dalla propria parte anziché dalla parte dell’altro inverte la logica relazionale: quando si parla di progetti, la luce dovrebbe stare sempre dalla parte degli utenti, siano essi fornitori, clienti o consulenti.
Le interferenze emotive o psicologiche rappresentano il tipo più insidioso: lo stato d’animo, le preoccupazioni personali, il retropensiero che occupa la mente mentre si comunica compromettono drammaticamente l’efficacia. Quando arriva un progetto importante ma contemporaneamente “nella pancia” ci sono altre tensioni, la comunicazione ne risente. Soluzione: praticare la presenza a se stessi, essere consapevoli del proprio stato emotivo prima di interazioni importanti. Se non si è presenti, meglio rimandare quando possibile. Durante l’interazione: concentrazione totale sull’interlocutore, ascolto attivo (non pensare alla risposta mentre l’altro parla ma ascoltare davvero), feedback continuo per verificare comprensione reciproca. La comunicazione a due vie, con continuo feedback, permette di correggere in tempo reale fraintendimenti causati da interferenze.
Agire con gentilezza non è debolezza né formalismo ma un risultato complesso da raggiungere che coniuga poetica (il significato profondo che emerge dal proprio agire) e modalità relazionale (come si trattano le persone). Comporta: sensibilità per stato d’animo proprio e altrui, attenzione alle emozioni che attraversano le interazioni, capacità di dire no senza offendere (assertività), rispetto per i punti di vista diversi, empatia senza necessariamente condividere. Esempio pratico: un fornitore propone una soluzione non adeguata. Risposta non gentile: “Questa cosa non va bene, non hai capito nulla”. Risposta gentile e assertiva: “Comprendo la tua proposta e apprezzo l’impegno; dal mio punto di vista ci sono alcuni aspetti che andrebbero rivisti per allinearsi meglio alle esigenze del progetto. Possiamo approfondire insieme questi punti?”. Stessa sostanza, impatto relazionale radicalmente diverso.
Prima: definire un obiettivo unico e verificabile, preparare un ordine del giorno con tempi e responsabilità, inviare i materiali in anticipo traducendo il gergo tecnico nel codice del destinatario per evitare interferenze semantiche. Durante: adottare comunicazione a due vie con feedback continuo, curare i tre canali (non verbale, paraverbale, verbale) perché il modo di presentare impatta più del contenuto; esplicitare termini ambigui e allineare i punti di vista per ridurre fraintendimenti; gestire le interferenze emotive con presenza e ascolto attivo. Dopo: sintetizzare decisioni, responsabilità e scadenze in un verbale di una pagina condiviso entro 24 ore; chiedere feedback su chiarezza e prossimi passi per verificare che il messaggio sia stato davvero compreso.
L’autocontrollo dipende dall’amigdala, che produce risposte istintuali velocissime finalizzate a liberarsi dall’ansia piuttosto che a gestire consapevolmente. Di fronte a stimoli nocivi (critica al progetto, obiezione del cliente), la reazione istintuale è controreagire. Sviluppare autocontrollo richiede: primo, accorgersi che si sta per reagire istintivamente; secondo, fermarsi un attimo prima di rispondere, respirare, prendere tempo (“Interessante punto, fammi riflettere un momento”); terzo, considerare risposte alternative che affermino la propria posizione senza prevaricare l’altro (assertività). Quarto, dare risposta garbata anziché quella che emotivamente verrebbe dall’amigdala. Questo è un’abilità che si sviluppa con pratica: ogni volta che si sbaglia, meditare sull’errore e correggere.
La comunicazione è essenzialmente un fatto tecnico: trasferire informazioni. La relazione è un fatto sociale: stabilire un rapporto tra persone. La differenza include: nella relazione c’è empatia, fiducia, arricchimento reciproco, dimensioni emotive assenti nella mera comunicazione. Una relazione senza empatia paradossalmente non è una vera relazione. Per gli architetti questo è cruciale: non basta comunicare tecnicamente bene i contenuti (il progetto, le specifiche, i costi); occorre costruire relazioni che generino fiducia, coinvolgimento e collaborazione.
Come riconoscere e gestire le zone d'ombra dell'intelligenza emotiva che compromettono le relazioni?
Le zone d’ombra includono: ambizione priva di regole, perdita della considerazione per gli altri, ragionevole bisogno di riconoscimenti trasformato in necessità patologica di essere continuamente osannati, convinzione della propria perfezione. Riconoscerle richiede autoanalisi onesta: fare lista di caratteristiche forti e deboli, chiedere feedback a colleghi fidati, osservare quando le relazioni falliscono e chiedersi cosa ha contribuito al fallimento dalla propria parte. Gestirle: consapevolezza è il primo passo (se riconosco il problema posso lavorarci); secondo, ricordare che è l’altro che conta, non l’ego; terzo, praticare umiltà intellettuale, riconoscere che si può sbagliare e imparare dagli altri; quarto, chiedere feedback esplicito dopo interazioni importanti (“Come ti è sembrato il nostro incontro? C’è qualcosa che avrei potuto fare diversamente?”).